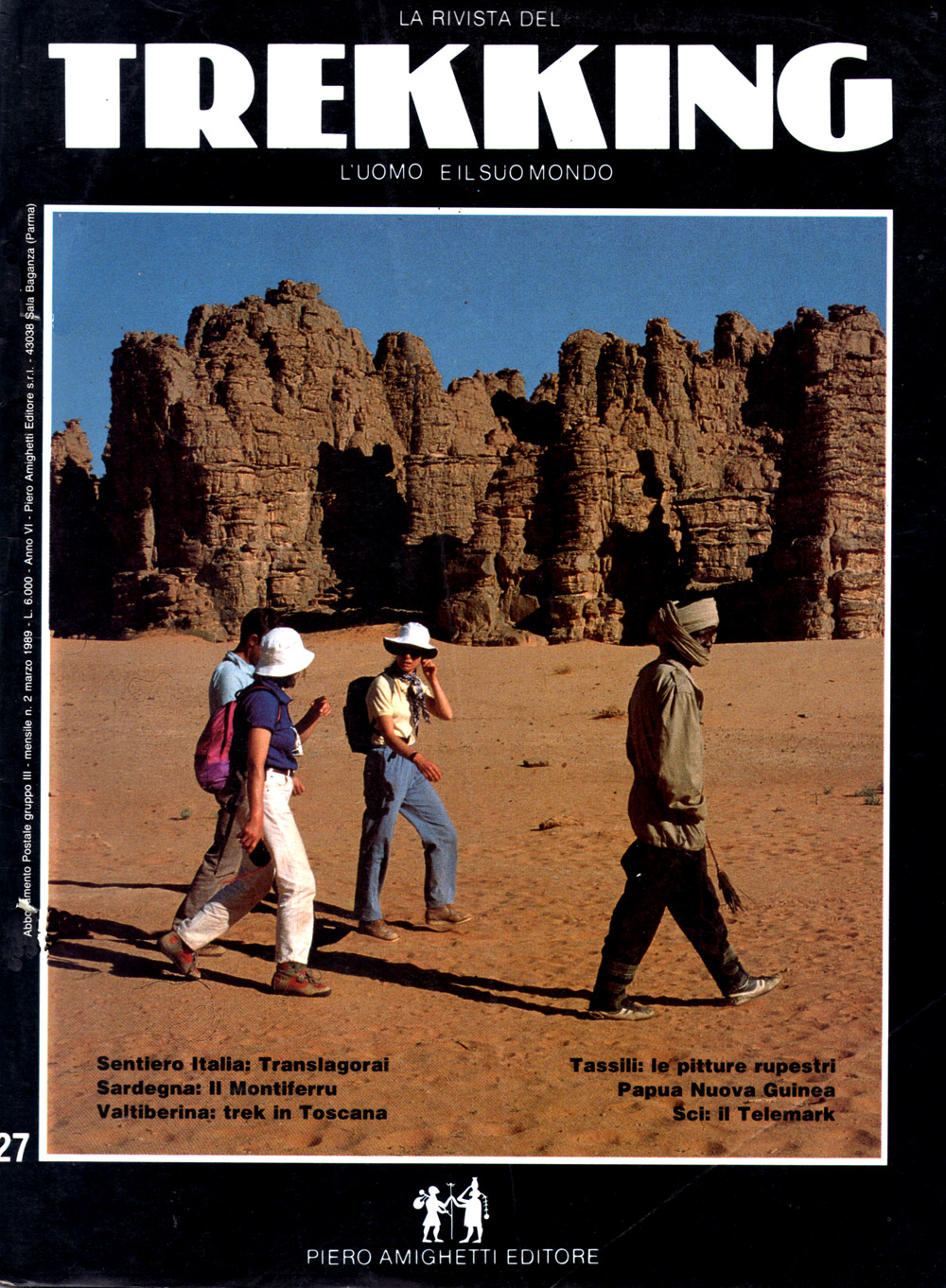Archeologia
Archeogalley
Presentiamo in questo numero l'itinerario proposto dagli studenti della scuola media statale «A. Segni» di Santu Lussurgiu (Oristano) che hanno partecipato al Premio Nazionale per un trek storico, etnografico, naturalistico organizzato dalla nostra Rivista.
IL MASSICCIO VULCANICO DEL MONTIFERRU
L'itinerario che rappresentiamo si sviluppa in una delle zone più suggestive della Sardegna: il massiccio vulcanico del Montiferru. In questa regione, più che altrove, storia e natura si fondono così intimamente da fornire l'immagine di un'unità territoriale ricca e affascinante, ancora tutta da scoprire.
Siamo sulla parte orientale dell'imponente catena, agevolmente raggiungibile dalla S.S. 131 Carlo Felice, attraverso gli svincoli di Macomer, Abbasanta, Paulilatino e Tramatza. La regione è incentrata sul cono vulcanico da cui ha preso il nome e ne comprende gli espandimenti basaltici fino alla pianura oristanese a Sud, al mare ad Ovest, al Rio Mannu a Nord e al monte S. Antonio a Nord-Est.
Caratterizzato dal tipico paesaggio d'altopiano nelle zone pedemontane e da svettate che superano i mille metri ricche di numerose e abbondanti sorgenti d'acqua freschissima e leggerissima dalle quali si formano lunghi e tortuosi torrenti spezzati da ripide cascate, il Montiferru appartiene amministrativamente alla XIV Comunità Montana e alla Provincia di Oristano.
Abitata sin dal primo neolitico e largamente nel periodo nuragico, la regione in età punico-romana aveva come capoluogo la città di Cornus, rasa al suolo dal console T. Manlio Torquato nell'anno 537 di Roma, dopo la sconfitta dei sardo-punici di Amsicora.
Di tali testimonianze è piena l'intera regione: domus de janas, nuraghi, città sepolte, costituiscono le tappe privilegiate per gli appassionati di archeologia.
Nell'Alto Medioevo, il dipartimento del Montiferru apparteneva al giudicato di Torres e il castello omonimo, del quale ancor oggi è possibile osservare i resti, ne costituiva il confine con quello di Arborea; con la caduta dei giudici, il Montiferru fu incorporato alla corona d'Aragona e ceduto in feudo a Guglielmo di Montagñans che lo vendette alla famiglia Zatrillas nel 1421 per 6 mila fiorini d'oro.
Nel 1670 il feudo venne confiscato a donna Francesca Zatrillas perché accusata di concorso in omicidio e lesa maestà, e venduto a don Francesco Brunengo; ma, nel 1709, per indulto di Carlo III, il feudo venne restituito a don Gabriele Aymerich - Zatrillas.
Passata la Sardegna alla Casa Savoia nel 1720, il Montiferru continuò a stare nelle mani di vari feudatari fino al 1848 quando anche l'Isola poté godere dei benefici della Costituzione concessa da Carlo Alberto.
L'attività economica prevalente della regione è quella agro-pastorale (molto rinomati i cavalli anglo-arabo-sardi allevati a Santu Lussurgiu), con un ricco e apprezzatissimo artigianato che trova i suoi esempi migliori a Cùgliri e a Santu Lussurgiu.
ITINERARIO (Tempo di Percorrenza: 6 ore)
Santu Lussurgiu - Nuraghe Piriccu -
Banzos - Matziscula -
Santu Lussurgiu
È proprio da Santu Lussurgiu che prende il via il nostro trek, a lungo preparato in classe con i nostri insegnanti, in biblioteca presso il Centro di Cultura Popolare UNLA, e più volte variato nel percorso e rinviato a causa del brutto tempo. Vi partecipano le prime e le seconde classi dei Corsi ''A'', ''B'' ed ''E”, in tutto una settantina tra alunni e insegnanti. Il tempo in questa fine di maggio è ancora incerto, ma l’attesa e i rinvii hanno portato l'entusiasmo alle stelle e si decide di partire!
SANTU LUSSURGIU - NURAGHE PIRICCU
 La partenza è fissata alle ore 8,30 dalla Scuola Media "Antonio Segni" di Santu Lussurgiu. All'uscita del paese, percorriamo un breve tratto della s.p. Santu Lussurgiu - Abbasanta, poi al bivio, sulla destra, quella per Paulilatino, recentemente sistemata.
La partenza è fissata alle ore 8,30 dalla Scuola Media "Antonio Segni" di Santu Lussurgiu. All'uscita del paese, percorriamo un breve tratto della s.p. Santu Lussurgiu - Abbasanta, poi al bivio, sulla destra, quella per Paulilatino, recentemente sistemata.
Sull'asfalto numerosissimi bruchi annunciano pioggia, così ci ha detto un anziano signore; ma non c'importa, proseguiamo.
Quella che attraversiamo è la zona dove gli abitanti di Santu Lussurgiu coltivano con cura estrema la vite: veri e propri giardini dedicati a Bacco! Dopo qualche chilometro, sulla destra, imbocchiamo uno stretto sentiero che, delimitato da altri muri a secco e numerose cancellate, conduce a "Mura Puddighina".
Dall'esame delle carte fatto a scuola, sappiamo che il nostro itinerario attraversa una regione densamente popolata di nuraghi, sia sul lato destro che sul sinistro: Mura/Lavros, S'Adde' e S'Inferru, Matta Ittiri, Chentianu, Camputzola, Su Mullone, Mura Surzaga, Campu Iscudu, e tanti altri.
Si tratta per lo più di nuraghi di piccola mole, alcuni ancora in piedi, molti altri in rovina; per l'appassionato c'è proprio l'imbarazzo della scelta!
Ma la nostra meta è definita da tempo ed è forse la più interessante. Non ci attardiamo oltre e, percorso a fatica l'ultimo tratto del sentiero di M. Puddighina, ingombro di rovi e muri a secco crollati, dopo una curva, in lontananza sulla sinistra, scorgiamo l'imponente sagoma di Nuraghe Piricu.
Proseguendo sullo stesso sentiero e svoltando a destra, ci inoltriamo in regione Mura Maiore dove, poco distante, in località Baragontu, ci attende la megalitica costruzione.
A Nuraghe Piricu sostiamo per circa un ora, facciamo colazione e tante domande ai nostri accompagnatori sull'origine dei nuraghi e sulla questione tanto controversa del loro utilizzo da parte dell'antico popolo nuragico. Poi, zaino in spalla, di nuovo marcia verso il secondo tratto del nostro itinerario.
 Per giungere a Banzos percorriamo il sentiero che attraversa le regioni di Mura Sulzaga e Camputzola.
Per giungere a Banzos percorriamo il sentiero che attraversa le regioni di Mura Sulzaga e Camputzola.
Sulla destra, possiamo osservare il deposito d'acqua di Santu Miale, che rifornisce la città di Oristano; e, proseguendo, giungiamo al bivio per Paulilatino e Santu Lussurgiu; tiriamo dritti sulla strada asfaltata.
Nell'aria c'è molta umidità e l'ora scelta per questo spostamento non è delle migliori: dobbiamo pranzare e il caldo afoso ci sovrasta. Per fortuna siamo poco distanti da Banzos e lì potremo rifornirci d'acqua fresca, mangiare e riposarci.
Passiamo davanti alla Scuola Agraria di Banzos, lascito della nobile famiglia Meloni ai lussurgesi perché vi realizzassero un moderno istituto di studi; ma i cancelli sono chiusi e la Scuola non funziona da anni. Poco più avanti, finalmente, facciamo sosta. Nell'abbeveratoio a sinistra della strada, sotto un ponte, è necessario attendere molto per rifornirci d'acqua: i nostri compagni l'hanno preso letteralmente d'assalto.
Iniziamo a sistemarci per consumare il pasto, ma non ne abbiamo iltempo: un violento acquazzone ci costringe a ripararci in una stalla, oltre la strada, e chiedere ospitalità al proprietario che ci accoglie di buon grado. Si pranza e ci si riposa. L'acquazzone ci costringe a variare i nostri programmi. E pensare che i bruchi questa mattina ci avevano avvertito!
Avremmo dovuto visitare i ruderi di epoca romana situati in una campagna poco distante dall'abbeveratoio, ma è tardi e preferiamo raggiungere Matziscula, meta sicuramente più interessante.
 Per giungere a Matziscula proseguiamo sulla strada di Banzos che ci immetterà nuovamente sulla Provinciale Santu Lussurgiu - Abbasanta.
Per giungere a Matziscula proseguiamo sulla strada di Banzos che ci immetterà nuovamente sulla Provinciale Santu Lussurgiu - Abbasanta.
Non piove più e sulla strada diversi operai e mezzi meccanici provvedono alla sistemazione del fondo per completare il manto stradale. Ci guardano con curiosità e ci salutano.
La zona che attraversiamo è molto ricca di corsi d'acqua: Riu de Bau Pirastru, Riu de Santu Predu. Dopo qualche chilometro, ci troviamo sulla Provinciale per Abbasanta, poco prima della frazione di S. Agostino. In regione Pranu 'e Fenu, a metà della curva chiamata Sega Broccas, deviamo a sinistra percorrendo un piccolo sentiero tra l'erba che, risalita una collinetta, ci conduce a Matziscula.
Fatichiamo un po' per trovare le tombe del periodo neolitico ivi esistenti a causa dell'erba alta e dei rovi: mafinalmente riusciamo a rintracciarle.
Le quattro Domos de Janas di Matziscula e quella di Mandra 'e Caddos di cui diamo qui la descrizione, sono ricavate in quegli affioramenti rocciosi assai frequenti nella piattaforma basaltica che si estende tra Santu Lussurgiu e Abbasanta.
Le popolazioni neolitiche che abitarono questi luoghi utilizzarono per le loro tombe tali modeste sporgenze realizzandovi sepolture mono e bicellulari.
Le cinque tombe hanno in comune le seguenti caratteristiche:
1) gli ingressi sono tutti a fior di suolo;
2) il livello dei pavimenti è inferiore a quello delle soglie;
3) le piante dei vani seguono una linea curva irregolare;
4)anche le pareti delle celle si sviluppano irregolarmente a tratti curve e a tratti dritte;
5) ciascuna presenta un corridoio scoperto (dromos) più o meno lungo che conduce all'ingresso;
6) tutti i portelli d'ingresso sono incorniciati da un profondo incasso dove presumibilmente veniva collocata la lastra di chiusura.
La prima fra le quattro tombe di Matziscula ha l'imbocco rivolto a settentrione su un piano inferiore a quello del terreno circostante, ed è costruita da due cellette intercomunicabili, la più piccola delle quali è totalmente visibile all'esterno perché la sua volta rocciosa è stata sfondata in tempi remoti dai cercatori di tesori.
La seconda domo di Matziscula situata a pochi passi dalla precedente ed è scavata entro un masso isolato tondeggiante emergente per un metro dal suolo. È bene in vista anche il suo ingresso che si trova alquanto al disotto del livello del terreno antistante. Anche questa seconda tomba è bicellulare. I due portelli d'accesso sono disposti sul medesimo asse e orientati a meridione. La parete ad ovest della seconda cella presenta un segmento verticale ricavato nel mezzo della parete stessa, lungo 50cm. a sezione trasversale semicircolare, che sbalza in altorilievo per 4 cm.
La terza tomba si trova a brevissima distanza dalla precedente ed è ricavata da un piccolo masso basaltico di forma conica sormontato da un muro a secco. Questa domo è di tipo monocellulare e si presenta con un'apertura incassata nel masso per circa 50cm. Il portello è a livello del terreno ed è rivolto ad est-nord-est.
Anche la quarta tomba di Matziscula è monocellulare e si apre alla base di uno spuntone roccioso situato proprio dietro il masso della tomba precedente, ed è ugualmente sormontato dallo stesso muro a secco. La sua apertura è a fior di suolo ed è orientata ad est.
La Domo de Janas di Mandra 'e Caddos è bicellulare ed è stata scavata in un affioramento basaltico a terrazza non molto distante dalla strada Santu Lussurgiu - Abbasanta e da quella che abbiamo percorso provenendo da Banzos. In questa tomba i pavimenti sono coperti da ciottoli e fanghiglia perché all'interno vi scorre una vena d'acqua perenne.
Dopo la ricognizione alle Domus de Janas di Matziscula e a quella di Mandra 'e Caddos, rimaniamo per qualche tempo sulla collinetta di Matziscula, facciamo una piccola merenda e intoniamo qualche canzone.
Ma si è fatto tardi e qualche goccia di pioggia ci consiglia di far rientro. Benedetti bruchi! Con una lunghissima fila indiana ripercorriamo la Provinciale verso Santu Lussurgiu. Alcuni nostri genitori ci raggiungono in macchina per darci un passaggio, ma oramai siamo vicini e vale la pena di farcela da soli!
APPUNTI SULLA VEGETAZIONE SPONTANEA DEL MONTIFERRU
Per un escursionista intelligente il Montiferru costituisce un autentico paradiso. Un visitatore attento non può non apprezzare i valori naturali di assoluta eccezione che si sono conservati intatti in questo monte. Vi crescono alberi che sono importanti relitti vegetali ed una flora spontanea che potrebbe presentare, sorprese e novità per il naturalista. La sua zona cacuminale è completamente priva di vegetazione arborea. Vi domina la gariga a timo. Numerose sono le specie erbacee spesso radenti al suolo a causa dei venti. È facile percorrere a piedi i numerosi sentieri che la attraversano. Durante una escursione si possono facilmente osservare abbondanti formazioni di timo, lavanda, elicriso, ed alcune forme basse di ginestra, erica, rosa canina. Alcune di queste piante sono fortemente aromatiche e conferiscono un profumo incomparabile alla passeggiata. L'interesse principale del Montiferru è però legato al paesaggio del leccio. Se l'evoluzione fosse naturale, tutto il monte sarebbe coperto da un enorme lecceto, grazie alle condizioni ambientali fresche per l'altitudine ed umide per la presenza di sorgenti perenni. Spettacolari sono i frammenti di formazioni forestali "chiuse" impenetrabili che ancora sopravvivono nel versante occidentale del monte, esposte ai venti impetuosi che vengono dal mare, in aree alquanto scoscese e di difficile accesso, ciò che ha favorito la loro conservazione. Queste foreste, caratterizzate dal leccio, dal lillatro, dall'erica e dal corbezzolo, sono formazioni vegetali a più strati, talvolta rese inestricabili dalle lianose. Interessanti sono anche le formazioni di muschi che ricoprono le pietre, ed i licheni che numerosi pendono dai rami degli alberi. Di più facile accesso, più luminoso e più comune come estensione è il bosco misto di leccio e caducifoglie, tra le quali domina la roverella, spesso accompagnata dall'acero minore e da magnifici esemplari di agrifoglio, alcuni alti anche 5-8 metri, che allo stato attuale costituiscono dei veri e propri sopravvissuti vegetali. E presente nel Montiferru un'altra formazione di origine molto antica che si è conservata allo stato naturale solo in poche zone della Sardegna: la macchia ad alloro che possiamo ammirare a sud di Santu Lussurgiu. Un'altra quercia ben rappresentata in questa fascia del Montiferru è la quercia da sughero, un albero la cui diffusione è favorita dall'uomo e dal fatto che è molto resistente agli incendi. Anche il castagno trova qui condizioni adatte al suo sviluppo. Non è però ancora accertato se sia una specie endemica o se sia stato introdotto in tempi antichi. Ciò che pare sia successo per l'olivastro che allo stato spontaneo non cresceva in Sardegna ma fu importato per uso alimentare dai Fenici. Le formazioni miste a leccio e sughero, sono abbastanza luminose, sia per la struttura aperta degli alberi sia per la distanza fra essi. Questo fatto ha favorito lo sviluppo di una folta macchia mediterranea caratterizzata dalla presenza soprattutto di: corbezzolo, erica, ginestra, cisto, lavanda, biancospino, rosa di macchia. Importante è la presenza di numerose essenze medicinali come: digitale, belladonna, scilla, stramonio, achillea, malva, sambuco ed altre. Anche lo strato erbaceo è caratterizzato da una enorme varietà di specie alcune delle quali hanno un ruolo fondamentale nell'alimentazione del bestiame domestico e conferiscono pregio e qualità ai prodotti della pastorizia lussurgese. Spesso il pastore, per utilizzare in modo più proficuo le numerose specie erbacee, provvede a diradare gli alberi e talvolta amplia le superfici a pascolo distruggendo, con l'incendio, la macchia mediterranea che tenderebbe a riempire interamente il suolo. L'incendio modifica e semplifica profondamente la struttura vegetale del pascolo. Si arriva così alla nascita di un nuovo paesaggio: il prato-pascolo, caratterizzato da vaste estensioni coperte da una vegetazione monospecifica con rari alberi.
PARTICOLARI DELLA FAUNA DEL MONTIFERRU Il Montiferru è un vasto complesso montano di origine vulcanica, situato nel settore centro occidentale della Sardegna. La fauna è particolarmente interessante perché caratterizzata da specie di animali rare, alcune, in via di estinzione. Tra questi il muflone sardo è un ungulato di piccola taglia. Vive di preferenza in ambienti rocciosi ed in dirupi con boscaglie e macchie, si nutre di erbe, germogli, frutti e più di ogni altro ungulato, si adatta a brucare fogliame con forte predilezione per le oleacee (olivastro, filliree). Questo bellissimo animale, che si considera estinto nel resto dell'Europa (tranne che in Corsica e a Cipro), è presente in Sardegna in circa 3.000 esemplari. Tra la famiglia dei suidi troviamo il cinghiale. È un animale onnivoro, pascola preferibilmente nelle ore crepuscolari, scava alla ricerca di tuberi, radici, bulbi, larve, insetti, lombrichi; appettisce inoltre ghiande, rettili, roditori. È facile incontrarlo con la sua famigliola di circa 4-8 cinghialetti, durante le ore crepuscolari quando d'abitudine si sposta dal suo nascondiglio per procurarsi il cibo. Alla famiglia dei canidi appartiene la volpe, che frequenta di preferenza gli ambienti rocciosi ricchi di vegetazione e anfratti. Nel Montiferru è da non dimenticare l'asinello sardo, così chiamato per le dimensioni più minute rispetto a quello continentale. Ancor oggi, si può osservare nelle campagne, lungo le strade o nel paese la cui vita è prevalentemente agro-pastorale. C'è ancora il cavallo sardo, del cui allevamento il Montiferru ha sempre avuto grande tradizione. Il cavallo vero compagno del pastore sardo fino a che non è stato soppiantato dalla meccanizzazione, è oggi impiegato prevalentemente nelle manifestazioni ippiche, nel folklore e nel turismo equestre. Tra i rapaci, i grifoni sono avvoltoi che ormai sopravvivono in Italia, soltanto in Sardegna con una popolazione di settanta individui circa. Sul Montiferru sono state individuate e ripulite le aree in cui nidificavano i grifoni locali prima della loro scomparsa e nel 1987 sono stati reintrodotti venticinque esemplari sugli aspri costoni e sulle gole del monte. Un carnaio, costantemente rifornito, assicurerà in futuro la sopravvivenza degli animali. La pernice sarda, vive solo in Sardegna è una infaticabile camminatrice e vola solo per necessità. Il mimetismo delle piume del dorso consente loro di confondersi col terreno in caso di pericolo. Frequenta le radure e gli spazi aperti vicino al bosco o alle macchie di lentischio. Lì trova cibo e soprattutto quella protezione naturale e quei rifugi sicuri che limitano almeno parzialmente l'incidenza della caccia. La ghiandaia sottospecie esclusiva della Sardegna vive nei boschi fitti, privilegiando soprattutto i querceti.